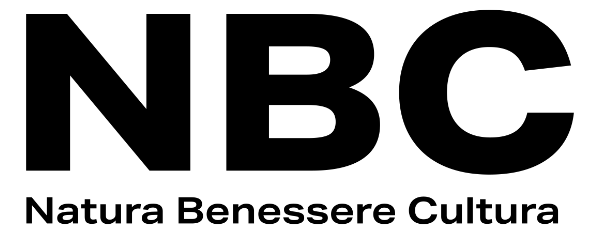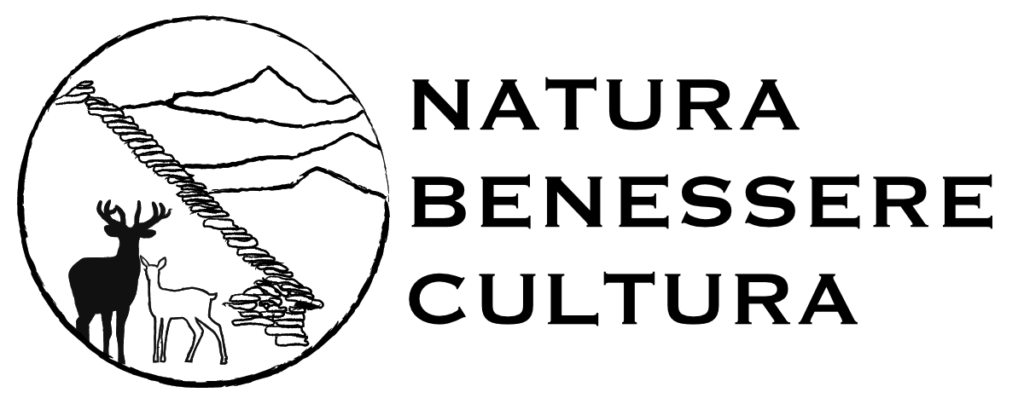Da mesi lavoriamo ad un Calendario dedicato alle donne. Abbiamo incontrato, conosciuto e raccontato decine di storie semplicemente uniche: una di queste è quella di Marina.
Per scattare la sua foto abbiamo trascorso con lei due giorni. Il primo senza risultato, ma fondamentale per il secondo in cui invece Marina ci ha aperto al suo mondo.
Un luogo magico che non è possibile trasmettere con un’immagine, ma che abbiamo intenzione di conservare qui.
Questa è la storia di Marina, Luglio 2025.
Il progetto “Donne di montagna”
Il progetto NaturaBenessereCultura – Calendario 2025 è nato con un’idea semplice ma potente: raccogliere 12 ritratti, 12 donne, 12 storie di montagna. Donne che non sono solo parte della montagna, sono la montagna: la lavorano, la ascoltano, la rispettano.
Ogni mese del calendario è dedicato a una di loro, con un ritratto in bianco e nero, un testo che la racconta e un QR code che rimanda all’intervista parlata.
Ma sul blog, ogni mese, vi portiamo un passo oltre: vi raccontiamo il dietro le quinte, le emozioni, le pause tra uno scatto e l’altro, il non detto che non si vede nell’immagine.
Luglio è dedicato a Marina, e questa è la sua storia.
Chi è Marina
Nel ritratto del mese di luglio, Marina è sulla soglia della sua vecchia stalla, con la caula appoggiata davanti a sé. Indossa un foulard annodato con cura, scarponi consumati dal tempo e dalla fatica, e porta sul volto la calma consapevole di chi ha attraversato le stagioni con coraggio e dignità.
Il suo ritratto vuole restituire visibilità e rispetto a quelle donne che hanno sostenuto, spesso in silenzio, l’equilibrio delle valli alpine. Donne che hanno saputo essere radici, forza e memoria dei luoghi.
Marina è una di loro e la storia dietro questo scatto è testimone di un patrimonio culturale che merita di essere ricordato, valorizzato e tramandato.
La storia dietro a questo scatto
Quel giorno a Pianezza il cielo era limpido e l’aria sapeva di fieno e legna tagliata da poco.
Un odore che racconta un’epoca: quella dei mesi estivi, in cui ogni famiglia si organizzava per l’alpeggio, per la fienagione, per mettere da parte ciò che serviva all’inverno.
Marina ci aspettava. Si era già preparata: foulard annodato con cura, scarponi ai piedi, e un sorriso che era insieme ironia e forza.
“Venite, vi faccio vedere.”
Ci ha aperto le porte della sua casa, ma anche della sua memoria. Ci ha guidato nella vecchia stalla, oggi deposito e luogo di conservazione, dove ogni oggetto aveva un nome, una storia, una funzione.

La caula, la brenta e la gerla
Ci ha mostrato la caula, una struttura in legno con due spallacci, che si caricava come uno zaino. Serviva per trasportare fascine di legna, fieno, gerle piene.
Usata soprattutto nei mesi invernali, quando si dovevano fare lunghi tragitti a piedi nella neve, la caula rappresentava la schiena della montagna: il corpo delle donne e degli uomini era il solo mezzo di trasporto disponibile.
C’era poi la brenta, usata per portare le vinacce, e la gerla, la cesta con intelaiatura in legno che serviva per il trasporto di qualunque cosa: legna, patate, bambini piccoli, quando si saliva in alpeggio.
E infine il torchio di famiglia, testimonianza del tempo in cui a Pianezza ogni nucleo contadino produceva il proprio vino. Il torchio funzionava a leva manuale: uva pigiata a piedi, poi vinacce spremute lentamente per giorni.
Il cervo e i ricordi d’infanzia

Poi è arrivata la valigia. Un piccolo scrigno di immagini: fotografie sbiadite di alpeggi, pascoli, animali, e un cervo.
“È arrivato un giorno, e da allora non se n’è più andato. Faceva parte della famiglia.”
Una frase semplice, ma potentissima. Racconta un mondo dove il confine tra selvatico e domestico era fluido, dove la montagna era un ecosistema condiviso.
Marina ci ha spiegato che l’alpeggio cominciava a maggio. Allora si saliva a piedi con 25-30 capre, 7 mucche e alcuni vitelli, caricando il necessario nelle gerle o nei basti degli animali.
Questo tipo di transumanza, detta anche “pastorizia verticale”, era l’unico modo per garantire cibo agli animali e prodotti per l’autosostentamento: latte, formaggi, burro.
“Le capre a volte non volevano tornare. Bisognava cercarle nei boschi. Chilometri e chilometri.”
La giornata cominciava all’alba con la mungitura e terminava dopo il tramonto, con la trasformazione del latte.
“Facevamo 120 litri di latte al giorno, di mischiato: mucca e capra. Poi si faceva burro e ricotta.”
Fino agli anni ’60-70, prima dell’avvento della meccanizzazione e della dispersione della società rurale, questo era il cuore pulsante della montagna: ogni famiglia aveva il proprio sapere tramandato, fatto di fatica, di ingegno, di rispetto per i cicli della natura.
Cosa ci ha insegnato Marina
A Luglio Marina ci ha insegnato una cosa che forse, oggi, troppo spesso dimentichiamo.
“I miei figli sono cresciuti con il latte di capra. È più leggero, più digeribile. Anche se noi donne, rispetto ai nostri figli, abbiamo un fisico diverso. Loro si stancano prima.”
Marina ci ha ricordato che le donne, spesso invisibili nella narrazione storica, reggevano sulle spalle l’intera economia domestica: accudivano animali, figli, producevano, trasportavano, conservavano.
E tutto questo senza motori, senza aiuti, senza scorciatoie.
“Facevamo tutto a mano, tutto a piedi.”