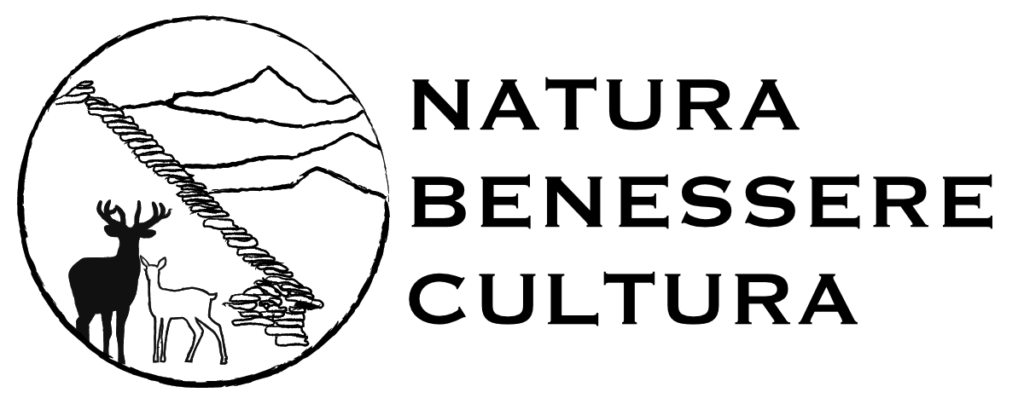Transumanza: cos’è, tradizione, quando e come avviene
La transumanza è un’antica tradizione pastorale in cui, durante la stagione estiva, gli animali di grossa e media taglia migrano dai pascoli di pianura a quelli di montagna. Dal 2019 è riconosciuta ufficialmente Patrimonio UNESCO Culturale Immateriale dell’Umanità.
Ma quando nasce? Come, quando e perché avviene? In Italia dove è ancora praticata?

Transumanza: cosa significa e dove nasce il nome?
Transumanza: in Abruzzo “rèntë”, in Puglia “r’masa” o “tratturo”, in Molise “strada delle greggi”, in Campania “armentizia” o “via dei pastori”, in Sicilia “nivaria”, “trasmuda” o “tràppola” nel Lazio e in Toscana, in Sardegna “sa tràmula”.
Cosa significa e da dove viene il nome?
Letteralmente, la parola “transumanza” significa “spostamento periodico di bestiame tra pascoli di pianura e alpeggi di montagna.”
Il termine affonda le sue radici dall’etimologia latina del verbo transumare, composto da trans (“attraverso”, “al di là”) e humus (“suolo”, “terra”).
Questo termine descriveva il movimento ciclico di uomini e animali attraverso territori diversi che collegavano pianure e montagne in cerca di pascoli stagionali.
Un’interessante e più complessa etimologia semitica (gruppo di lingue comprendente il babilonese e l’assiro, l’ebraico e l’aramaico, l’arabo e l’etiopico) richiama l’accadico taru (“girare”, “andare attorno”) e ummanu (“popolo”, “nazione”), suggerendo un legame profondo con la mobilità dei popoli.
La transumanza, quindi, rappresenta non solo uno spostamento fisico, ma una pratica ancestrale inscritta nella storia dell’uomo e dei suoi territori.

Quando e come avviene la transumanza?
In estate e in inverno
La tradizione della transumanza è una pratica complessa e al tempo stesso affascinante.
Avviene due volte all’anno, in momenti precisi della stagione e su sentieri che gli animali conoscono bene: i tratturi, itinerari che possono estendersi anche per centinaia di chilometri, sviluppandosi su dislivelli spesso molto impegnativi.
Prima dell’estate, i pastori portano il proprio gregge sui pascoli di appennino o alta montagna per permettere agli animali di godere di aria più pulita, temperature più fresche e soprattutto erba più genuina e naturale.

Con l’arrivo della stagione fredda, prima dell’inverno e solitamente a settembre, il gregge scende nuovamente in pianura per superare il gelo all’interno delle stalle, dove il clima è più mite e non manca il foraggio.
La salita in alpeggio e la discesa a valle
La transumanza si suddivide quindi in due fasi principali: la monticazione e la demonticazione, i momenti cruciali del ciclo pastorale.
La monticazione è il movimento verso l’alto, che avviene in primavera quando le greggi e le mandrie vengono condotte dagli allevatori verso i pascoli d’alta quota, chiamati alpeggi. Gli alpeggi sono vaste distese erbose situate a quote che possono superare i 1500 metri, dove durante l’estate l’erba cresce abbondante grazie al clima fresco e alle frequenti precipitazioni. Questi pascoli montani rappresentano una risorsa preziosa: il terreno, libero dalla neve e rigenerato dal riposo invernale, offre nutrimento di alta qualità per gli animali, favorendo la produzione di latte e carne più ricca e nutriente.

Nei secoli passati, i pastori si trasferivano con le famiglie in malghe o baite, semplici costruzioni in legno o pietra situate vicino agli alpeggi, dove passavano l’intera stagione estiva. Qui si svolgevano importanti attività di trasformazione del latte in formaggi, come il pecorino e la ricotta.
La demonticazione rappresenta il movimento inverso, che si verifica a fine estate o inizio autunno, quando gli animali devono abbandonare gli alpeggi man mano che il freddo e la neve ricoprono i pascoli montani. Durante questa fase, gli armenti vengono riportati verso la pianura, dove trovano riparo dal rigore invernale e pascoli più adatti al clima. Questo rientro consente di sfruttare le risorse delle pianure, che restano verdi e accessibili per gran parte dell’inverno. La demonticazione è anche un momento importante per gli allevatori, poiché segna il ritorno a una vita più stanziale, spesso vicino ai villaggi o alle fattorie.

Origine e diffusione della transumanza in Italia
La transumanza ha radici profonde nella storia italiana, risalenti probabilmente all’inizio dell’allevamento stesso.
Già nel 192 a.C., durante l’epoca romana, esistevano magistrature pastorali incaricate di regolamentare questa attività, a testimonianza della sua rilevanza economica e sociale.
Il periodo di massima diffusione della transumanza si colloca tra il XVI e il XVII secolo, quando oltre 4 milioni di pecore si spostavano annualmente dall’Abruzzo alla Puglia attraverso una vasta rete di tratturi. Questi antichi percorsi erbosi, alcuni dei quali risalenti all’epoca romana, collegavano le zone montuose dell’Appennino ai pascoli del Tavoliere delle Puglie.
I principali tratturi prendevano il nome dalle località di partenza e arrivo, tra cui:
- L’Aquila-Foggia: il più lungo, con una lunghezza di 244 km.
- Pescasseroli-Candela: 211 km.
- Celano-Foggia: 207 km.
- Castel di Sangro-Lucera: 127 km.
Durante il Regno di Napoli, l’importanza della transumanza era tale da richiedere la creazione di istituzioni specifiche per la sua gestione e amministrazione.
Tuttavia, l’abolizione della Dogana di Foggia nel 1806 e le leggi napoleoniche sull’affrancazione dei terreni demaniali segnarono l’inizio del declino di questa pratica tradizionale.
La transumanza oggi: una tradizione che resiste
Oggi la transumanza è ancora largamente impiegata in alcune regioni d’Italia, nonostante l’urbanizzazione e l’industrializzazione stiano minacciando una delle più antiche tradizioni del nostro territorio.
La transumanza orizzontale, detta anche mediterranea, è una pratica pastorale che comporta lo spostamento del bestiame tra aree di pascolo a quote simili, senza grandi variazioni altimetriche.
Questo tipo di transumanza è tipico delle regioni del centro-sud Italia, come la Puglia, la Basilicata e il Molise, dove i pastori spostano le greggi lungo antichi tratturi per ottimizzare l’uso delle risorse foraggere disponibili. Un esempio significativo è la transumanza che avviene tra il Tavoliere delle Puglie e le aree collinari dell’Abruzzo e del Molise, un percorso storicamente utilizzato per evitare il sovrasfruttamento dei pascoli invernali o estivi.
La transumanza verticale, o alpina, invece, prevede il movimento stagionale del bestiame tra pascoli situati a diverse altitudini, sfruttando il clima e la vegetazione più favorevoli a seconda della stagione. Durante l’estate, gli animali vengono condotti agli alpeggi in alta montagna, dove trovano erba fresca e temperature miti, mentre in inverno tornano a valle per evitare il freddo e la scarsità di pascoli.
Questa pratica è ancora viva in regioni come il Trentino-Alto Adige, la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Lombardia, con esempi celebri come la transumanza della Val Senales o quella della Valtellina, dove migliaia di capi di bestiame percorrono antichi sentieri tra le valli e le cime alpine.
In alcune di queste regioni è possibile partecipare alle cosiddette “feste della transumanza” per vedere dal vivo i grandi spostamenti estivi degli animali, respirare la loro stessa aria pulita e assaggiare i prodotti tipici.
- Anversa degli Abruzzi, Abruzzo
- “La Ritorna”, Villa Celiera – Abruzzo
- Amatrice, Lazio
- Bagnoli del Trigno, Molise
- Fiumefreddo Bruzio, Calabria
- Tremosine, Lombardia
- “La Scargàa di Alp”, Bognanco – Piemonte
Il riconoscimento di Patrimonio UNESCO Culturale Immateriale nel 2019
La transumanza non solo ha modellato il paesaggio rurale italiano, ma ha anche influenzato la cultura e le tradizioni delle comunità coinvolte, creando un patrimonio immateriale riconosciuto a livello internazionale.
Per questi motivi, dal 2019, la transumanza è stata riconosciuta universalmente dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, a testimonianza del suo inestimabile valore storico e sociale.
Non si tratta solo di un metodo di allevamento: la transumanza ha un’importanza culturale ed economica che mantiene vive antiche tradizioni e promuove i sapori autentici della nostra terra.
Scargàa di Alp: la celebre festa della transumanza in Piemonte
A Bognanco, un comune immerso nella selvaggia Valle Bognanco, in Piemonte, la transumanza è conosciuta bene.
Nella sua alta valle, infatti, sono prodotti alcuni dei formaggi più apprezzati dell’Ossola che proprio grazie a questa pratica raccontano il sapore della terre in cui nascono ad ogni boccone.
La “Scargàa di Alp” è una festa di montagna che ogni anno regala l’opportunità di vivere in prima persona tutto questo, a partire dalla discesa dall’alpeggio insieme agli animali, per finire con la degustazione dei prodotti fino a serate a tema con ospiti speciali, progetti e premi in grado di promuovere questa tradizione.

Si svolge solitamente col finire dell’estate, nel mese di Settembre, a Bognanco (Piemonte), per un weekend di divertimento, cultura e sapori veri.
La “Scargàa di Alp” non è solo un evento che celebra il passato, ma un invito a mantenere vive le tradizioni, riscoprendo la bellezza della natura.
Con ogni edizione, questa festa vi promette di trasformare il rito dello “scaricare l’alpe” non solo in una giornata in cui vivere la montagna, ma anche in un nuovo territorio di cui innamorarvi.