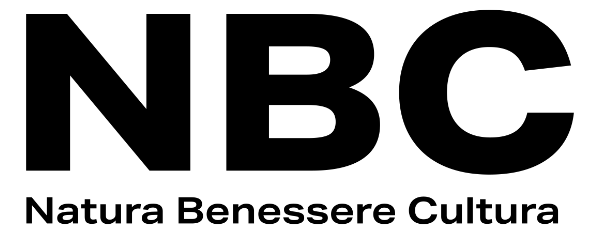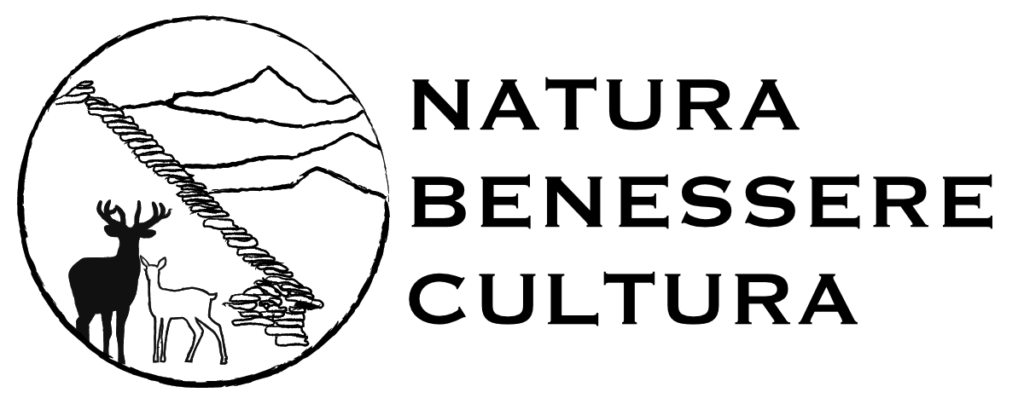Cos’è l’Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori
I pascoli, oggi, coprono più di metà delle terre emerse del nostro pianeta. La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) nel 2022 contava più di 3,2 miliardi di ettari di prati e pascoli permanenti su circa 4,8 miliardi di ettari di superficie agricola complessiva.
È dentro questa cornice che si colloca la decisione delle Nazioni Unite di istituire il 2026 come Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori. L’obiettivo, dice l’ONU è: “portare al centro della discussione pubblica la salute dei pascoli e la pastorizia sostenibile, insieme alla necessità di pratiche territoriali corrette, ripristino degli ecosistemi e investimenti responsabili in un settore che tiene insieme economie locali e stabilità ambientale.”
Non si tratta di un titolo celebrativo, e nemmeno di un riconoscimento di facciata: la scelta dell’ONU arriva in un momento profondamente delicato in cui il dibattito internazionale prova a ricomporre in un’unica traiettoria la transizione ecologica, la gestione del suolo e la sicurezza alimentare, cioè i tre fronti che più di tutti determineranno il modo in cui produrremo cibo e abiteremo i territori nei prossimi decenni.
E in Italia? Che ruolo rivestono i pascoli? Quanto è ancora importante questo settore? Qual è la sua storia e la sua tradizione?
In questo articolo ripercorriamo il viaggio che ci ha condotti fino ad oggi, all’anno 2026 come Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, partendo dalla storica tradizione della pastorizia in Italia e dal primo alpeggio alpino, per arrivare all’economia agro-silvo-pastorale dei giorni nostri e all’evento organizzato in Val d’Ossola che ha riunito i pastori e giovani produttori del territorio.

2002: l’Anno Internazionale delle Montagne
L’Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori non nasce come un’iniziativa isolata, ma si colloca dentro una crescente attenzione che le Nazioni Unite hanno progressivamente rivolto agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e, soprattutto, le comunità che li rendono abitabili.
La prima tappa di questo viaggio ecologico avviene nel 1992, con il Vertice della Terra di Rio de Janeiro.
È in questa occasione che nasce Agenda 21, un programma d’azione globale che segna l’ingresso dello sviluppo sostenibile nella pianificazione internazionale come obiettivo operativo, non come formula retorica.
All’interno di Agenda 21, il Capitolo 13 ha un valore particolare perché è dedicato alla “gestione degli ecosistemi fragili” e identifica le montagne come uno dei punti strategici della sostenibilità globale. È un passaggio rilevante per due motivi. Il primo è di metodo, perché colloca le terre alte nello stesso perimetro concettuale di grandi questioni planetarie come cambiamento climatico, deforestazione e desertificazione, riconoscendo che la vulnerabilità degli ecosistemi montani produce effetti a cascata sui territori circostanti. Il secondo motivo è politico, perché suggerisce che la montagna non può essere trattata esclusivamente come patrimonio paesaggistico, ma come sistema territoriale in cui si intrecciano risorse naturali, infrastrutture, economia locale, gestione dell’acqua, biodiversità e stabilità sociale.
Dieci anni più tardi, nel 2002, questa impostazione si traduce in un atto di attenzione globale più esplicito con la proclamazione dell’Anno Internazionale delle Montagne. Anche in quel caso la FAO viene indicata come agenzia leader, con un mandato orientato ad aumentare la consapevolezza internazionale sull’importanza degli ecosistemi montani e a promuovere la cooperazione tra governi, società civile e organismi del sistema ONU. Il 2002 consolida un punto che, fino a quel momento, era rimasto spesso implicito nelle politiche ambientali, cioè che parlare di sostenibilità significa parlare anche di territori “difficili”, di aree interne, di modelli economici non replicabili in pianura e di condizioni di vita che richiedono strumenti specifici.
Sul piano europeo, negli stessi anni, cresce la tendenza a distinguere la montagna dalle categorie generiche di “aree svantaggiate”, facendo emergere l’idea di politiche dedicate che tengano insieme classificazioni coerenti, misure di sostegno mirate e strategie di lungo periodo. In Italia, dove una parte rilevante del territorio rientra in classificazioni montane e migliaia di comuni dipendono dalla tenuta sociale ed economica delle terre alte, questa discussione ha un impatto diretto perché mette in relazione temi che spesso vengono trattati separatamente, come tutela ambientale, infrastrutture, servizi, lavoro e permanenza delle comunità.

2026: l’Anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori
Quando l’ONU decide di dedicare un anno a un tema, di solito c’è una ragione molto concreta. Nel caso del 2026 Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, la ragione è sotto i nostri occhi anche se spesso non la vediamo.
I pascoli non sono soltanto “prati”, né un pezzo di mondo relegato alle aree interne. Sono una delle grandi strutture naturali che tengono in equilibrio territori, economie e comunità, dalle Alpi fino alle praterie più lontane. E proprio per questo le Nazioni Unite hanno scelto di portare il tema al centro dell’attenzione globale, affidando alla FAO il compito di guidare e coordinare le iniziative legate all’anno internazionale.
La domanda, allora, non è che cosa “celebra” il 2026, ma che cosa prova a rimettere in ordine?
Prima di tutto, una consapevolezza. I territori pascolati, nel mondo, sono enormi, e la loro salute incide su tutto ciò che sta attorno. Un pascolo che funziona bene non è solo “bello”. È suolo vivo, acqua gestita meglio, biodiversità che resiste, paesaggi che non si chiudono e non si degradano. È anche lavoro, produzione di cibo, filiere locali, presidio umano. E quando questi sistemi entrano in crisi, la crisi non resta confinata “in montagna”, perché si traduce in abbandono, perdita di servizi, fragilità idrogeologica, incendi più frequenti, e in generale in territori meno resilienti.
È qui che entra in gioco la seconda parola chiave del 2026, i pastori. Perché l’Anno Internazionale non parla soltanto di ecosistemi, parla di persone. Di chi vive e lavora in questi ambienti, di chi li gestisce ogni giorno, spesso con una competenza che è al tempo stesso tecnica e culturale. Il pascolamento, quando è fatto bene, non è “lasciare gli animali a brucare”. È gestione del territorio, è equilibrio tra carico animale e capacità del prato, è lettura delle stagioni, è spostamento intelligente, è prevenzione. In molte aree del mondo la mobilità pastorale è una strategia di adattamento ambientale, non un’abitudine antica. Ed è uno dei motivi per cui la FAO insiste da anni su regole chiare e strumenti che proteggano la sostenibilità e la dignità economica di questo lavoro.
Poi c’è un terzo elemento, forse il più attuale. Il 2026 arriva mentre la pressione sui territori cresce. Siccità e fenomeni estremi, degrado del suolo, competizione per le risorse, malattie del bestiame, instabilità dei mercati. In questo scenario, l’Anno Internazionale non promette soluzioni magiche, ma chiede una cosa precisa. Che la gestione dei pascoli e la pastorizia tornino a essere considerate un tema strategico, quindi da sostenere con pratiche corrette, ripristino degli ecosistemi dove serve, investimenti responsabili e accesso più equo a servizi e mercati.
E qui arriviamo alle nostre montagne, perché per le Alpi e per l’Italia questo discorso non è astratto. Il pascolo, sulle terre alte, è una delle grandi leve che tengono aperto il paesaggio e che permettono la continuità di una civiltà alpina che non è fatta solo di turismo, ma di lavoro, prodotti, saperi, relazioni. Il 2026 ci offre una cornice internazionale per raccontare meglio quello che abbiamo sotto casa, senza ridurlo a cartolina e senza trasformarlo in uno scontro ideologico. È un’occasione per capire come ciò che accade sugli alpeggi sia legato a un tema globale e, allo stesso tempo, come una scelta globale possa diventare una lente utile per leggere il futuro delle nostre valli.
La pastorizia: un settore che tiene ancora in piedi l’Italia
In Italia i pascoli sono, ancora oggi, un settore diffuso e concreto che incide sull’economia rurale, sul presidio delle aree interne e sulla vita di migliaia di famiglie. La Superficie Agricola Utilizzata del Paese è stimata in 12.598.161 ettari, pari a circa il 41,8% dell’estensione nazionale, e una quota significativa di questa superficie è legata a prati e pascoli, cioè a quel mosaico di aree che permette di far vivere filiere zootecniche anche dove le coltivazioni “da pianura” non sono praticabili.

La pastorizia, poi, è tutt’altro che marginale. Le stime diffuse sulla filiera ovicaprina descrivono un Paese con oltre 7 milioni di ovini e circa 900mila caprini, distribuiti lungo l’Appennino, sulle Alpi e nelle Isole, con la Sardegna che resta il baricentro produttivo. Da qui nasce una parte importante dell’agroalimentare italiano. La filiera ovicaprina produce circa 600mila tonnellate di latte l’anno, e oltre il 60% viene destinato a formaggi DOP, con un indotto che supera 1 miliardo di euro e coinvolge oltre 60mila aziende.
Questi numeri non restano sulla carta, perché dietro ci sono aziende, trasformatori, cooperative, trasporto, commercio, turismo rurale e una parte importante del patrimonio agroalimentare italiano. La stessa filiera ovicaprina nazionale produce circa 600 mila tonnellate di latte all’anno e una quota rilevante finisce in formaggi Dop, con un indotto che supera il miliardo di euro e coinvolge circa 60 mila aziende agricole, oltre a migliaia di addetti lungo la catena del valore.
Insomma: la pastorizia non è solo produzione, è anche territorio.
In molte valli alpine e in tante aree appenniniche l’allevamento al pascolo è una delle poche attività in grado di tenere vive zone altrimenti destinate allo spopolamento, contribuendo alla manutenzione del paesaggio, alla tenuta dei prati, alla continuità delle pratiche tradizionali e a quella cultura materiale che, nei fatti, ha costruito una parte dell’identità italiana.
La prova è che il settore sta cambiando, ma non si sta spegnendo. Negli ultimi anni sono cresciute le aziende multifunzionali, aumentano le realtà che vendono direttamente, che integrano con agriturismo e didattica, e che trasformano il lavoro pastorale in un sistema più resiliente, capace di tenere insieme reddito e radicamento. E anche la transumanza, che in alcune regioni continua a essere pratica viva, è riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, un segnale che racconta quanto questo mondo non sia “folklore”, ma parte della storia contemporanea del Paese.
Per questo, quando l’ONU decide di mettere pascoli e pastori al centro del 2026, l’Italia non può guardare la notizia come qualcosa che riguarda soltanto altri continenti. Riguarda anche noi, perché qui pascolo e pastorizia non significano soltanto carne o latte. Significano economia reale, famiglie, lavoro, e la capacità di tenere abitabili e produttivi territori che, senza queste attività, rischiano di perdere non solo popolazione, ma anche identità e futuro.
La pastorizia come tradizione storica del nostro Paese
Il pascolo d’altura è una delle forme più antiche di gestione del territorio mai praticate dall’uomo, molto prima che esistessero l’agricoltura intensiva, le stalle permanenti e la zootecnia industriale.
Il primo alpeggio della storia, se così possiamo chiamarlo, nasce quando le comunità umane capiscono che seguire l’erba è più efficiente che consumarla tutta nello stesso luogo. Accade sulle montagne, perché è lì che la natura impone regole chiare: l’erba cresce solo per pochi mesi all’anno, la neve chiude l’accesso in inverno, le risorse sono limitate e vanno distribuite nel tempo. È in questo contesto che prende forma una delle grandi intuizioni dell’economia pastorale: spostarsi invece di accumulare, salire invece di forzare, alternare invece di sfruttare.
Le Alpi e l’Appennino diventano così, molto presto, un laboratorio di convivenza tra uomo, animali e ambiente.
Il primo alpeggio nella storia delle Alpi: Macugnaga, 999 d.C
Macugnaga occupa un posto speciale nella storia delle Alpi. È qui, ai piedi della parete est del Monte Rosa, che si colloca uno dei primi esempi documentati di alpeggio strutturato, già attivo in epoca medievale e probabilmente molto prima, nella forma di utilizzo collettivo dei pascoli d’alta quota.
L’Alpe Pedriola, in Valle Anzasca (area del Monte Rosa), è considerato uno dei più antichi alpeggi documentati dell’arco alpino. La prima attestazione storica compare in una pergamena del 999 d.C., in cui si registra un passaggio di proprietà tra enti ecclesiastici che include anche Pedriola. L’elemento di maggiore interesse, sul piano storico e agricolo, è la continuità d’uso: tra i terreni citati nel documento, Pedriola risulta l’unico in cui ancora oggi si produce formaggio.

Nel Novecento, l’alpeggio entra stabilmente in una dimensione pubblica. Nel 1904 l’area viene ceduta al Comune insieme ad altre proprietà, con una clausola di prelazione a favore della popolazione locale. In termini di governance, è un passaggio importante perché lega l’uso del pascolo alla comunità, riducendo il rischio di alienazioni o utilizzi esterni non coerenti con l’interesse territoriale.
La gestione contemporanea dell’Alpe Pedriola è stata rilanciata nel 2016 dall’azienda agricola Madalù, che ha avviato un processo di recupero funzionale delle strutture e di ripristino della trasformazione in quota. In una prima fase l’alpeggio è stato utilizzato senza caseificazione per limiti strutturali, poi sono stati realizzati adeguamenti tali da rendere possibile un caseificio conforme anche in alta quota. Oggi l’attività zootecnica è basata su una mandria ridotta con razze rustiche, adatte ai versanti alpini, e rappresenta un esempio concreto di continuità produttiva su pascoli storici.

La tradizione dell’alpeggio e della transumanza
Alpeggio e transumanza sono due pratiche diverse ma strettamente collegate, perché descrivono, insieme, il modo in cui la zootecnia di montagna ha imparato a usare il territorio in modo razionale e sostenibile. L’alpeggio riguarda soprattutto l’estate e la permanenza in quota, la transumanza invece definisce lo spostamento stagionale complessivo del bestiame tra pascoli differenti, costruendo un ciclo annuale che alterna valle, mezza montagna e alta montagna. In entrambi i casi, il principio è chiaro e ancora attuale: sfruttare in modo alternato le risorse foraggere disponibili, evitando il sovrasfruttamento dei prati e garantendo alimentazione agli animali senza trasformare la montagna in un sistema artificiale.
L’alpeggio
L’alpeggio è la forma più tipica del pascolo alpino e consiste nel trasferimento del bestiame verso pascoli d’alta quota durante i mesi estivi, quando le condizioni climatiche e vegetative rendono disponibili superfici che per il resto dell’anno restano improduttive. La monticazione avviene in genere tra fine maggio e giugno, in funzione dell’altitudine e dell’andamento stagionale, mentre la demonticazione si colloca tra settembre e ottobre, quando le temperature e le prime nevicate riducono la crescita dell’erba. Il bestiame viene gestito su pascoli differenziati per quota ed esposizione e, dove la gestione è corretta, si applica una rotazione interna che preserva la copertura vegetale e mantiene la produttività nel tempo.
La transumanza
A differenza dell’alpeggio, che descrive una fase specifica legata alla permanenza estiva in quota, la transumanza rappresenta un sistema più ampio e definisce l’intero ciclo annuale dell’allevamento estensivo. In Italia si è sviluppata in due forme principali. La transumanza verticale, tipica delle Alpi, collega pascoli di fondovalle e alpeggi, seguendo il gradiente altimetrico e la stagionalità della vegetazione. La transumanza orizzontale, caratteristica dell’Appennino centro-meridionale, interessa invece lunghe distanze su quote simili, lungo percorsi storici come i tratturi che collegavano le aree montane ai grandi pascoli invernali.
La rilevanza economica di questo sistema, in alcune fasi storiche, è stata enorme. Tra il XVI e il XVII secolo la transumanza raggiunge in Italia il massimo sviluppo, con milioni di capi movimentati annualmente lungo una rete regolamentata da istituzioni specifiche. Non era soltanto una tecnica di allevamento, ma un’infrastruttura territoriale che organizzava commercio della lana, produzione casearia, economia rurale e rapporti sociali in vaste aree del Paese. Il declino inizia tra XIX e XX secolo, con riforme fondiarie, frammentazione della proprietà, industrializzazione dell’agricoltura e riduzione delle superfici disponibili. Tuttavia, la transumanza non è scomparsa e continua a essere praticata in molte aree, soprattutto in forma ridotta, come strumento di gestione sostenibile del territorio.
Nel 2019 l’UNESCO ha riconosciuto la transumanza come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità perché è molto più di uno spostamento di bestiame. È un sistema di saperi pratici, regole condivise e competenze tramandate che, stagione dopo stagione, permette di usare il suolo senza consumarlo. E lo stesso vale per l’alpeggio, che oggi torna al centro del dibattito su pascoli e sostenibilità non per nostalgia, ma per efficacia. Dove questa pratica è ancora viva, resta uno dei modi più solidi per tenere insieme economia di montagna, cura del paesaggio e continuità culturale, con una precisione che pochi altri modelli produttivi riescono a garantire.
“L’orgoglio di lavorare in montagna”: in Valle Vigezzo si riuniscono pastori e giovani produttori della Val d’Ossola
“Dopo il 2002 “Anno internazionale della montagna”, la nuova indizione dell’ONU offre anche alla Val d’Ossola l’occasione di un momento di orgoglio identitario. Il primo alpeggio documentato sulle Alpi è stato a Macugnaga nel 999 d.C. Dopo mille anni, altri giovani continuano un’impresa di civiltà, declinata in termini moderni.”
Il Rosa, Periodico di Cultura Alpina

Organizzato dal Comune di Toceno e dal periodico di cultura alpina “Il Rosa”, sabato 24 gennaio a Toceno (Sala polifunzionale, ore 9,30) si terrà l’evento “L’orgoglio di lavorare in montagna”, incontro con i giovani allevatori e produttori della Val d’Ossola in occasione del “2026: anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori” indetto dall’ONU.
Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali, l’intervento di Paolo Crosa Lenz su “Mille anni di uomini e alpeggi sui monti dell’Ossola. L’orgoglio di una civiltà alpina” e di Ornella Barre (Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “Innocenzo IX” di Baceno) su “Il ruolo della scuola agraria di Crodo”. Seguiranno, in dialogo con i redattori de “Il Rosa”, i racconti di vita e di esperienza degli allevatori ossolani: Luca Marta e Damiano Brega (Valle Anzasca), Francesco Zanola (Alpe Veglia), Lara Pennati (Val Formazza), Jodi Maccagno (Val Bognanco), Giacomo e Marco Prina (Valle Antigorio), Barbieri Berini Ielmoli Pensa (Valle Vigezzo).
In conclusione Patrizia Testore, presidente del premio letterario “Salviamo La montagna” dialogherà con il Museo “Tax – Xierfa” di Malta per un confronto di pastorizia con un’isola del Mediterraneo.
L’evento si avvale del patrocinio dell’Unione Montana Valle Vigezzo, Valli dell’Ossola, Alta Ossola, Media Ossola, Lago Maggiore, Pro Loco Toceno e Gruppo Alpini di Toceno.